Giacomo Joyce
- 11 dicembre 2014 Cultura
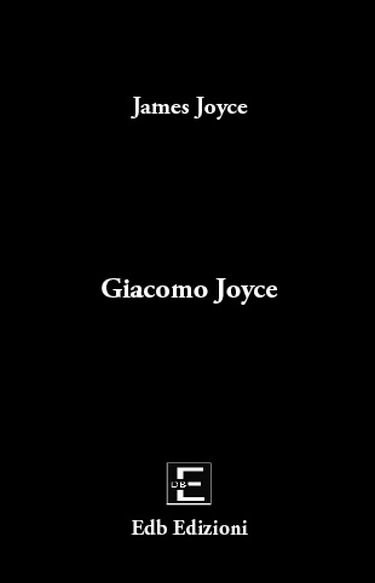
Non troverete in queste poche righe introduttive un saggio sull’autore dell’Ulisse, una simile impresa necessiterebbe di ben altre misure.
Questa è solo una presentazione dell’opera più sorprendente di Joyce, sconosciuta ai più e introvabile, che si chiude in sedici intensissime pagine: l’ultimo scritto pubblicato, la cui stesura precede l’Ulisse – probabilmente inedito per ragioni personali che si intravedono nell’intreccio della vicenda. Attraverso questa proposta esemplare vogliamo mostrare le possibilità della prosa nella ricerca sul linguaggio. Oggi che il romanzo sopravvive solo come feticcio commerciale e che la poesia si intasa in un’elite neanche troppo coesa, meglio rifugiarsi nei beni non deperibili della letteratura universale. Inutile chiedere aiuto alla critica, ormai completamente estinta, sostituita da uno sbrodolamento inefficace di concetti e corrotta né più né meno degli altri settori del paese, con firme improbabili che ci dicono come dovremmo scrivere o comportarci.
Il Giacomo Joyce non è un’opera incompiuta ma la scoperta di una nuova scrittura, quella poetica, e in particolare della prosa poetica. In fondo, questo è un poemetto d’amore. Ma stiamo parlando di Joyce e quindi anche l’amore diventa micidiale se, per esempio, coincide con la fine della giovinezza. Generazioni di scrittori hanno dovuto (e dovranno) fare i conti con queste pagine, che si offrono come un infinito serbatoio d’invenzione e sentimento. Un immenso lavoro sul linguaggio che non sfuggirà al lettore più attento: compatto, semplice e diafano, scriveva Richard Ellmann, ma anche crudele tanto è netto. Una scrittura scanzonata e controllatissima, carica di senso e di doppi sensi, privata quasi di sintassi e traboccante di immagini liriche. Un Joyce da culto, a briglia sciolta, da passeggiata con se stesso, senza bisogno di finzioni letterarie. Nonostante la forma frammentata e sincopata, l’attrito del reale è energico e sonoro: «- Why? - Because otherwise I could not see you. - Sliding – space – ages – foliage of stars – and waning heaven – stillness – and stillness deeper – stillness of annihilation – and her voice... Unreadiness. A bare apartment. Torbid daylight. A long black piano: coffin of music». Da notare l’uso degli spazi bianchi, variabili e protagonisti, quasi fossero indicazioni di durata, unità del silenzio. Onirico e combattuto, pandemico e celeste, questo taccuino ha la cadenza dell’eccitazione: il ritmo cresce fino alla «pace dell’annientamento», in cui morte e amore si fondono.
Tutto il testo si regge su trabocchetti e enigmi, implicazioni culturali e collegamenti letterari: da Omero a Thomas Nash, a Mallarmé, passando per la «più profonda quiete» di Leopardi, fino all’ironica Senilità di Svevo. Ogni pagina ricorda il motto di Mies Van der Rohe «Less is more», senza mediazioni, minimale e furiosa. Un libro d’amore che, non a caso, rimonta fino a Shakespeare. Per questa ragione «Crossing in love» è stato tradotto «sfortune d’amore», per il richiamo alle stelle incrociate del drammaturgo. C’è anche un riferimento esplicito alle «stelle fredde», e al senso di amore “astrale” e complicato. E in generale tutto il testo è attraversato da echi shakespeariani - dall’amletico «Hillo, ho, ho, boy! Come bird come» agli spettri da cacciare con le candele: «Give me some light: away! – Lights, lights, lights!». I versi citati, invece, provengono, nell’ordine, dal John Gilpin di William Cowper e dal The Cenci di Byron. Da non dimenticare l’allusione al Tesoro di Brunetto Latini e a Ibsen, che lo scrittore ammirava profondamente - da qui la citazione di Hedda Gabler.
A chi abbia amato Ulisse, sembrerà di trovarsi nel backstage del romanzo: «Ulisse è la ragione. Simbolo della coscienza intellettuale... L’Irlanda allora? E il marito? Percorrendo il corridoio in ciabatte o giocando a scacchi contro se stesso. Perché siamo abbandonati qui? Proprio adesso la parrucchiera era stesa qui, a stringermi forte la testa tra le sue ginocchia nodose... Simbolo intellettuale della mia razza». Il taccuino è una scala a pioli verso l’Ulisse: dalla narrazione in terza persona del Ritratto dell’artista ai monologhi interiori di Bloom. Subito troviamo il riferimento all’occhialetto, al monocolo, che riporta alla signorina Bellingham e, poco oltre, come fa Stephen, viene citato Gioacchino da Fiore. Che Joyce consultasse il Giacomo al suo ritorno a Trieste nel 1919 quando stava lavorando all’Ulisse è evidente, per esempio, nell’analogia con l’episodio delle mandrie al sole, anche lì le «voci si fondono e si mescolano... Una regione dove il grigio crepuscolo sempre discende... Angendath è una terra desolata, ricetto di gufi e della miope upupa». La ragazza del Giacomo diventa Millicent e gli stivaletti intrecciati faranno parte della punizione di Bloom. Allo stesso modo l’invocazione a Ignazio di Loyola ritorna identica nella bocca di Stephen. Idem per il risveglio di Trieste, che però si trasforma in Parigi. Amore sì, ma anche fine della giovinezza. Sebbene scritto da un Joyce poco più che trentenne, il protagonista si sente un uomo di mezza età, ringiovanito solo dall’amore e dall’incapacità di gestirlo. Un «adulterio della saggezza» con tanto di simbologia del gufo: un libro notturno, sporco ma impeccabile. Con l’avvicinarsi della vecchiaia la letteratura può solo dare conto di tale perdita: «La giovinezza ha una fine. Nella vaga foschia di vecchi suoni appare un punto di luce debole: il discorso dell’anima sta qui per essere ascoltato. La giovinezza ha una fine: la fine è qui. Non accadrà mai. Tu lo sai bene. E allora? Scrivilo, dannato, scrivilo! Cos’altro sai fare?».
Il libro uscirà a metà dicembre.
Alberto Pellegatta







