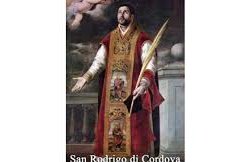ASSASSINIO A BORDO 5
- 12 marzo 2021 Cultura

Ritornai al Los Angeles Examiner, dove mi ritrovai faccia a faccia con la bella Alexandra che, riconosciutomi aumentò l’intensità del suo sorriso come un reostato che dalla luce media passasse di colpo alla massima.
- Hello! - salutai.
- Hello! - rispose.
- È passato poco tempo da quando ci siamo lasciati- esordii, - ma pur poco per me è sempre molto. Per cui, eccomi qui nuovamente!
Lei apprezzò la sparata, seppure incerta perché non conosceva ancora il motivo della mia visita.
- Vorrei – le dissi - poter consultare i numeri arretrati del giornale - le spiegai. - A che piano si trova l’archivio?
- Al primo. Mi rilasci un documento che poi le do il pass.
Tolsi dal portafoglio la carta di identità, che prese per ricopiarne i dati. Già dalla volta precedente aveva appreso dalla mia voce che ero un detective privato, ma nel leggerli stampati sul documento le sembrò assumessero un valore maggiore. È l’effetto benefico che spesso assumono le parole stampate sulle carte statali, a parte i documenti di sfratto e quelli di fallimento.
- È interessante la sua professione? - domandò.
- Quando mi reco in banca ad incassare il compenso pattuito, certamente sì.
Il sorriso tornò sulle sue belle labbra come un sole luminoso.
- Magari qualche volta avrà modo di raccontarmi qualcosa sulla sua professione…
- Magari davanti a una tazza di caffè – dissi, - oppure a una cena in un buon ristorante.
Presi il pass che mi porgeva e mi avviai lungo la sala che immetteva ai piani superiori. Mentre varcavo la soglia dello stanzone dove i giornali arretrati erano raccolti, mi imbattei nella aggraziata figura di Lorella Pearson, raccolta anch’essa nel suo portamento. Quando mi vide sussultò, già sulla difensiva.
- Tranquilla. Vengo qui in pace, come una belva alla sorgente: della fonte della verità.
Se non che la belva non ero io, bensì lo era quella che mi stava di fronte. Mi allontanai da lei, che mi osservò perplessa. Al banco della ricezione richiesi gli arretrati del giornale risalenti alla seconda metà di aprile del 1945. L’addetto allo smistamento, un uomo sulla cinquantina di razza bianca, di aspetto simpatico e vestito dignitosamente, annuì e mi fece accomodare a un tavolo, già occupato in parte da alcuni studenti tra i quali una ragazza molto bella che nel vedermi sorrise, un sorriso pulito, che era un piacere vedere e un privilegio ricevere. Io, che di anni non ne avevo molti più di lei, potevo ancora permettermi il lusso di rispondere al suo sorriso, e magari cercare di invitarla fuori a fare una passeggiata, una promenade sul boulevard dei passi perduti. Arrivò quindi il grosso volume che raccoglieva i numeri del quotidiano del mese di aprile. Le notizie provenienti dal fronte campeggiavano sulle prime pagine, com’era naturale che fosse, ma io era su quelle interne e precisamente su quelle dello spettacolo. Fu qui che trovai la notizia. Thomas Incerwood era morto perché il suo cuore si era improvvisamente fermato - come se tutti noi non morissimo perché il nostro cuore si ferma - forse per un qualcosa che doveva avere mangiato. Lasciava la moglie e un grande vuoto fra i suoi colleghi e ammiratori, l’ultima cosa non sempre si poteva abbinare alla prima.
I funerali si erano svolti il diciotto di aprile, e la salma dopo la cremazione era stata tumulata nel cimitero di Westwood di Hollywood.
Restai con le pagine del giornale fra le mani, intento a riflettere. Poi richiusi il volume, che già puzzava di vecchio e di stantio, mi alzai, sorrisi alla ragazza e riportato il tutto sul bancone ad eccezione della ragazza ringraziai l’impiegato e lasciai lo stanzone. Ridiscesa la scala a passo rapido mi ritrovai al pianoterra, dove ritrovai anche la bella Alexandra. Sorrisi anche a lei con l’aggiunta di una strizzatina d’occhio: quello sinistro, che mi serve per prendere meglio la mira - e infatti avevo delle mire su di lei. – dicendole:
- A presto - le dissi con aria complice. D’altronde lei doveva essere sui venticinque anni, io ero sulla trentina per cui ancora c’era il margine giusto di differenza di età permissibile che non era il margine del davanzale sul quale tentennare prima di buttarsi giù.
Lasciai il palazzo della Stampa per fare ritorno alla mia auto.
Thomas Incerwood aveva abitato in una sontuosa villa di Beverly Hills. L’edificio era immerso nel verde della vegetazione presente. Di stile italiano tardo Settecento, alta due piani e con tanto di finestre ampie dai vetri piombati, si trovava a duecento metri dal cancello di nero e oro dipinto, il vialetto inghiaiato fiancheggiato da prati ben tosati come pecore uscite dalle cesoie del pastore, o contribuenti dalle grinfie degli esattori del fisco. Piante sempreverdi che per la loro manutenzione abbisognavano di una quantità industriale di acqua potabile si intravedevano attraverso le sbarre del cancello, mentre si vedevano invece per intero roseti e altre piante profumate, più le onnipresenti palme le cui caratteristiche chiome parevano quelle di selvaggi africani prima dell’intervento delle forbici del parrucchiere. Suonai il campanello e aspettai.
Di lì a poco una figura femminile vestita con la mise di domestica si palesò per avanzare poi verso il cancello.
Si trattava di una donna ancora giovane e bella, il cui viso man mano che si andava avvicinando era come se al tempo stesso si allontanasse, perché sospinto all’indietro da un certo orgoglio, caratteristica talvolta della sua professione, che deve necessariamente mantenere un certo distacco.
- Sì? - mi si rivolse dopo essersi fermata a un paio di metri dal cancello.
- Mi chiamo Lew Miller, sono un detective privato. Vorrei parlare con la signora Incerwood.
- Ha prima telefonato? - si informò.
- No - confessai. È stata una ispirazione improvvisa - aggiunsi sorridendo.
Lei non restituì il sorriso, forse comprendendo che non ne valeva la pena.
- Attenda qui. Vado a vedere se la signora è disposta a riceverla.
Voltò le terga che aveva di notevole qualità e si riavviò lungo “il sentiero del pino solitario”.
Antonio Mecca